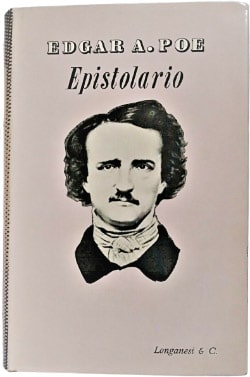Gli appassionati di Fantascienza in Italia lo sanno. Se vogliono essere aggiornati su cosa bolle in pentola nel panorama mondiale del fantastico (novità, commenti, ricerche, e capolavori pregressi) c’è una sola autorevole rivista letteraria dedicata al tema: DIMENSIONE COSMICA edita dal Gruppo editoriale Tabula Fati. Puntuale, esauriente, qualificata. Nell’ultima edizione della primavera 2023, la suggestiva copertina di ispirazione medievale con una attraente fanciulla guerriero, realizzata da Andrej Vasilcenko, attira l’attenzione. Tema principale di questa edizione la Fantascienza russa, introdotto e commentato dalla penna sagace di Gianfranco de Turris con articoli, racconti, analisi, commenti. Illuminanti gli interventi di Sacha Cepparulo, Andrea Gualchierotti, Eugenij Lukin.
Di seguito riportiamo uno dei racconti pubblicati sulla rivista:
LE GROTTE DEL SARACENO
Sono costretto a rivelare il contenuto della corrispondenza di un amico creduto scomparso, sul quale ora si scagliano veleni. Tradirò la discrezione imposta dalla sua volontà liberandomi tuttavia di un peso. Rendendo pubblici i suoi scritti custodi di storie antiche e cronache recenti svelerò un’atroce verità. Non occorre sia esplicito nel citare nomi, un fragile diaframma li separa da persone note in zona in cui la vicenda, col suo tragico epilogo, è maturata. L’imbarazzante corrispondenza nelle mie mani abbraccia un cospicuo arco di tempo e ha il sapore di un diario-testamento, nonostante le lacune e l’incomprensibile mancanza di cenni a moglie e figlio che egli peraltro amava.
Fra le pagine due fogli strappati e stropicciati. Una calligrafia incerta sottolineata in rosso recita: “Il canonico Giuseppe De Conti annota che il territorio di San G… contiene una singolarità nella regione detta di M….essa consiste in che per longa estensione esistono tuttora scavate nel tufo, tortuose e diramate grotte, capaci di ricovero di moltitudine di persone, dai contadini chiamate le Grotte del Saraceno.” E poi: “…dopo lunghissime indagini d’archivio pensiamo di avere identificato le quattro epigrafi, due delle quali già note – risalenti al 1626, o agli anni successivi, che comprovano certe affermazioni: “L’anno mille sei cento venti sei li fu fatto rottura a tutti sei”, ovvero l’indicazione dell’anno in cui il governo mantovano decretò la morte dei briganti confinati nelle caverne… colà murati vivi con uomini e cavalli…”
E infine lo stralcio di una lettera: “Il 28 novembre 1954 il padre cappuccino Innocenzo Piòvera mi scrive: Chiarissimo signor conte di A., ricordo benissimo di essermi recato a O. e nel sopralluogo eseguito di aver riscontrato tracce di metalli nel sottosuolo, ferro e anche di oro, ma dato il tempo trascorso non ho più presente né la loro entità né la profondità dove si trovano.” …Nel 1926 padre Piòvera, le cui doti di rabdomante e sensitivo erano apprezzate, durante la prima campagna di scavi, accompagnato da un confratello, cadde in autoipnosi proprio all’ingresso delle caverne. Riferì di aver visualizzato un vero e proprio squarcio di un tempo e di uno spazio alieni, diversi da quelli correnti, sorta di finestra aperta nel tunnel dei secoli, confermando così antiche narrazioni…”
Il significato oscuro si chiarisce leggendo quanto di suo pugno l’amico aveva scritto e ora in mio possesso:
O.M. 196…
Scalda l’animo al solo vederla. Ridente, eppur severa, con un imponente camino di mattoni piantato sul tetto. Bizzarro e armonico miscuglio di stili, la loro villa. Dentro ci vive col marito, storico di vaglia, la mia amica, pittrice di misconosciuto talento. Ecco che mi ha visto arrivare. Incontenibile la gioia nel vederci. Ci abbracciamo forte, rubandoci la parola. Fra poco saluterò il marito, conte di A., anch’egli contento di avermi per qualche tempo ospite. Ad attenderci pare ci sia una lepre annegata nel vino. Il soggiorno promette bene. Avremo tutta la serata per parlare degli infausti Saraceni che infestavano la zona nel X secolo, riducendo in cenere abitazioni e chiese, coadiuvati dai mali homines, indigeni con cui avevano fatto combutta.
O.M. maggio 196…
Dal conte apprendo per sommi capi le vicende, drammatiche, che per duemila anni si sono prodotte in zona, interessando misteriose caverne e certi agghiaccianti particolari.
Gli ipogei di S…provano il susseguirsi di tre cicli storici, il primo dell’età romana attesta l’esistenza di un Mitreo, luogo di culto del dio sole, nelle stesse caverne, con materiale tuttora ivi sepolto. Il secondo ciclo attesta la presenza dei Saraceni nel X secolo, come confermano i cronisti dell’epoca e reperti archeologici. Il terzo ciclo vede l’occupazione delle caverne di soldati disertori, sbandati, frequenti nelle guerre seicentesche, lì presenti nel 1620-1625.
Altri documenti “intoccabili” risalenti al 1600, sono conservati in un faldone sul ripiano più alto della libreria del conte, seminascosti da un tendone.
O. M. 196…
Non ho preso sonno. Mi hanno tenuto sveglio i racconti del conte il cui umore è mutato. Stiamo scendendo verso le grotte. Anche la mia amica, solitamente loquace, tace. Il cielo si è fatto livido, la boscaglia ci sovrasta, ovunque rovi alti come un uomo ci impediscono. Il disagio è palpabile. Indugiamo davanti all’ingresso secondario, ce n’è un altro che solo il conte conosce. Sono deluso e mi chiedo: tutto qua? Infatti vedo solo un buco fra la parete di tufo e il suolo. Sono in tanti a credere che il mio ospite sappia molto di più di quello che vuol far credere. Negli anni in molti si sono affannati a cercare là sotto un fantomatico tesoro, lasciando tracce che poi si sono sovrapposte.
O.M. 196…
Amo tutto di loro: casa, libri, i fox terrier, e soprattutto,
il coraggio di esprimersi contro corrente, solidali con la Tradizione. Sediamo sugli scalini dell’ingresso. La notte sciorina una trapunta di buio luminoso. Viatico per la mia felicità. Scriverò con lettere dorate gli avvenimenti a cui partecipano tre spiriti votati al bello, all’onorevole passato, rinnegando le convulsioni del presente. Non respiro quasi per tema di guastare l’incanto. Giuro a me stesso che mai contaminerò il nostro legame, geloso della nostra amicizia. Ho il cuore gonfio, sposterei montagne per loro, ma ho da offrirgli solo la mia umbratile sensibilità di adolescente.
Nei discorsi ancora i Saraceni, Berberi del Marocco, naufragati nei pressi di Saint Tropez, per poi in forze, dilagare e saccheggiare il Piemonte, spegnendo anche il vescovo di Asti Eilolfo. Rovine dietro di loro. Li immagino tendere agguati, crudeli e smodati antagonisti della nostra storia.
“E poi i sarcofagi,” sussurra con teatrale astuzia il conte.
“Quali sarcofagi?” chiedo allibito, sotto il cielo che si è rabbuiato.
“Sì, due giganteschi guerrieri scolpiti nel tufo, con le mani sull’elsa della spada. Sepolcri di arabi, a quanto dicevano i testimoni, per via di certe iscrizioni illeggibili sulle pietre tombali.”
Era troppo per me quella notte. Ma il mio ospite aggiunse: “Gli addetti alla cava avranno distrutto i reperti, compresa una chiesetta romanica, per non mettere in allarme la Sovrintendenza che avrebbe bloccato i lavori.”
O.M. giugno 197…
È bella, un frutto maturo dal fascino antico. Maestra, sorella, amica, confidente. Una capigliatura di oro chiaro sempre scomposta le incornicia il volto come una nuvola. Il destino ha voluto farmi dono della sua amicizia, il destino, geloso, provvederà a separarci. La guardo, affascinato, dopo aver ammirato alcuni dei suoi ultimi dipinti, che accatasta, forse per pudore, contro il muro, celandoli alla vista. Non vedo l’ora di passeggiare con lei. Quando siamo in due le confidenze corrono più fluide. Ne avrò di cose da chiedere sui Saraceni.
O.M. 7 giugno 197…
Emma arriva puntuale, tuttofare non ancora sfiorita. Così ficcanaso da frugare fra le carte del conte celate alla vista. Ma è devota alla mia amica. A suo cugino cacciatore si deve la lepre sotto vino. Quando se ne va il conte scoppierà in sonore risate sostenendo che la serva si è invaghita di me. E alla sera si parlerà ancora delle caverne del Saraceno. Così il conte:
“Padre Innocenzo Piòvera aveva confermato certe mie supposizioni. Ero riuscito a parlare con chi aveva scavato nella valle del G…. I due fratelli andavano laggiù, col padre, anche di notte, facevano tre turni, per non rallentare lo scavo. Una galleria di 36 metri, larga due avevano fatto, incredibile! E senza i mezzi di oggi. Ho parlato con entrambe; riempivano secchi di tufo sbriciolato, a centinaia. Senza alcuna causa apparente ripetevano di aver sentito dei boati venire da dentro la collina, e loro non volevano farci caso, e che i secchi col tufo appena scalpellato cominciavano a…ballare, poi si alzavano.”
“Come…si alzavano?” chiedo attonito.
“Volavano per aria, scagliati da forze tremende contro soffitto e pareti della galleria. Poi si sentivano dei rumori…come tronchi e rami che si abbattono, e anche…”
“…Cosa?…” sussurro implorando di ridurre l’indugio. La mia amica mi fa cenno di pazientare.
“…lamenti sempre più forti, urla disperate, disumane,” dice il marito.
Una coltre di sgomento mi avvolge mentre il conte: “Ho sentito prima uno, poi l’altro fratello e il loro racconto non mostrava discordanze. Gente semplice, si turbavano ancora al ricordo. Uno di loro, più sensibile del fratello e del padre, probabilmente innescava fenomeni paranormali con la sua sola presenza. ‘Quando mio fratello Gino non c’era a scavare si stava tranquilli… non succedeva niente’ diceva uno dei due.”
“E poi succedeva dell’altro?” chiedo ansioso.
“Sì”
“Cosa?” oso.
“… Galline chiocciare. Nel ventre della collina, galline. E poi un altro fatto inspiegabile: su una delle pareti si proiettava una fosforescenza, che anch’io ho visto.”
6 ottobre 199…
Vado a trovarli col mio caro amico, l’editore delle opere del conte, la tristezza mi gonfia il cuore mentre la ghiaia del viale scricchiola. Mi pare ancora di sentire la voce della mia amica, le risate di lui, invece no, sono scomparsi da anni. Attraverso il cancelletto della tomba introduco un mazzo di gerbere. Addio amici, penso, trattenendo le lacrime.
26 ottobre 2019
Alterno periodi di relativo ottimismo a convulsioni dell’umore. In questi momenti il passato mi perseguita con insulse lusinghe. Non disdegno la caritatevole benevolenza di alcuni negozianti Sick che hanno messo su bottega vicino casa. Fra verdura e frutta immangiabili ci sono anche cose commestibili e toast scaduti da un giorno. Quanto durerà questo degrado che non è solo economico? Sono solo.
Senza data
Ho traslocato. La vita cittadina era troppo cara. Qui la mia giovinezza ha conosciuto tempi migliori, qui ho assaporato l’amicizia dei miei amici. Non è stato difficile trovare fra le cascine disertate dai villici, per fare i tranvieri in città, all’inseguimento del “progresso”, una che facesse al mio caso e, perdipiù, a un tiro di fucile dalla casa in rovina dei miei amici scomparsi.
Sena data
Ho sviluppato una facoltà sorprendente. Essa si attiva nel trapasso dal sonno alla veglia, quando le immagini oniriche sembrano non abbandonare la mente. Scene che reiterano nel dormiveglia la loro estraneità col quotidiano corrente. Accade così che i Saraceni tornino alla ribalta col loro magnetico mistero. Questo, forse, il vero motivo che mi ha fatto cercare dimora nei pressi della caverna e della villa.
Quando vidi Emma incorniciata nello stipite della porta, un profondo turbamento mi spinse a balbettare, non udito: “È proprio lei Emma?” La vecchia che era sempre stata, mi riconduceva a loro offrendomi i suoi servigi senza che l’avessi cercata, e senza far mostra di riconoscermi. Ero dunque così mutato? Avevo timore mi riconoscesse. Veniva due volte la settimana per spostare la polvere da un posto all’altro della povera casa.
“A lei piace la lepre?” chiese un giorno. Trasalii affrettandomi a negare. Poi un mattino le chiesi: “Chi abita lassù?” Turbata, disse: “Oh! Più nessuno c’è, lassù, da anni. La signora contessa e il conte, dei veri signori, sa? E lui cercava il tesoro, anche. Aveva segreti che nessuno sapeva, sa? È entrato nelle grotte quand’era giovane, anche!”
Simulai disinteresse ma la donna parlò ancora. Mi addormentai a stento, sognai di sognare pur cosciente che tutto era vero. Una febbre strana mi assaliva a intervalli al solo immaginare cosa mi attendeva laggiù, richiamato dalle sirene del passato, dalla leggenda delle grotte fatta storia. In me prendeva vita la loro impronta che mi faceva amare il loro ricordo, la Tradizione, il Passato e i suoi riti perduti.
Senza data
Nemmeno oggi uscirò. La smagliante tessitura della luce incide come un bisturi il paesaggio: il sole gioca sugli arazzi verde e viola, sulle chiese dalle mura consunte su cui il tempo ha scolpito bizzarri geroglifici. Tutto risplende, opprimente. Un luogo come questo coincide con la periferia della vita. I miei nervi mal sopportano l’assalto della memoria di un bene goduto e poi perduto. Ma una forza oscura mi tiene inchiodato là, come se avessi dovuto “coincidere” con i reperti in sfacelo dei pressi.
Ho licenziato Emma inventando una mia lunga assenza. Non sopportavo averla tra i piedi. Vittima di quel luogo mi consumavo nel desiderio di appartenervi. Ma in che modo?
Giugno 2021
Non esco se non di notte. Nessuno sa che sono qua. Sto sfuggendo alle fauci del buio, ma sino a quando? Ho cominciato a sognare la mia amica. Severa, sfuggente. La sua scontrosità mi ferisce, non era mai stata così con me. Vorrei chiederle spiegazione ma si nega, come se l’avessi delusa, contrariata. Comincio a delirare, ho timore del nuovo giorno. La caverna mi attende, lo so.
Senza data
Ho timore di non riconoscermi allo specchio. Evito ogni contatto. L’unica certezza rimasta a torturarmi e di cui non riesco a dare ragione è che nella veglia trascino incubi fatti di memoria così veraci da spaventarmi. Sgomenta sapere che essi vivono paralleli alla vita vera.
Giugno 2021
Devo affrettarmi e osare. Là sotto c’è la vita che cerco. Non distinguo la veglia dal sogno. Scivolo in un incubo che mi porta nel ventre della valle dove si aprono le caverne del Saraceno:
Vapori umidi e spessi si alzano dal suolo. Sterpi secchi, bruciati da infiorescenze di brina. L’apertura è un rettangolo basso di tufo scalpellato. Ho paura. Non è un luogo fisico questo, ma un brano di tempo fissato in un Tempo-spazio che lo isola, saturo di parvenze, vanamente indagate, e ora accese in me. In balia di un tempo alieno, vago.
Ho dei fiammiferi e un mazzo di stecchi secchi. Mi sembra di scorgere un bagliore. Sottoterra?! Accendo il primo fiammifero. La camera è bassa. Sulla destra un tavolo di pietra, stretto e lungo. Il fianco del tavolo si conficca nella parete. Il primo stecco si spegne. Il secondo illumina un’altra apertura, sono camere basse, una consecutiva all’altra, nel secondo ambiente devo chinare il capo. Il pavimento è in discesa. Scolpite sul lato inferiore di un cornicione tre teste di toro. Rimasugli di coppe e bacinelle riposano su una mensola murata. Su alcuni frammenti si innestano manici, con il capo a forma di aspide, figurine di scarabei collegati con minuscoli festoni di fiori e frutti scolpiti. Tutto è infranto, sommerso dall’onda dei secoli.
Forme indistinte di metallo… forse i rilievi di padre Piòvera? Opachi diademi di morte!
Davanti al biancheggiare di ossa ridotte a pietrame la mia mente cessa. Scheletri fosforescenti, confusi con lame brandite dalle sole ossa metacarpali. Un pattume di ossa emerge dal pavimento, frammisto al morso di ferro ancora in bocca ai cavalli. Crani equini e teschi umani, ancora appesi al loro cappio, privi dello scheletro, crollato a terra. La fiammella del quarto stecco si estingue. Non hanno urlato tanto questi resti umani quanto ora sta urlando il silenzio. Ma sono io che grido insieme ai murati vivi. Stavo raccogliendo i frutti dell’aconito, che dispensa follia e morte.
Senza data
Complice una notte senza luna scendo verso la grotta. Mi affanno fra nuvole di rovi. Indugio davanti all’ingresso laterale, indicato dal conte. Mi infilo nel cunicolo. Da una fessura filtra una luce fosforescente come se provenisse da una… camera ardente?! La camera! c’è ancora, sottratta alla devastazione della cava. Ovvero la tomba del guerriero arabo che stringe l’elsa della sua spada di tufo. Domani tornerò qui. Mi stenderò di fianco a lui. Chiuderò gli occhi. Per sempre.
Rileggendo la testimonianza mi prende una gran tristezza. L’angoscia impotente fa il resto. Oggi stesso consegnerò la corrispondenza ricevuta agli inquirenti che indagano sulla scomparsa del mio amico. Allora tutto sarà tragicamente chiaro.
Per cercare riscontri occorre consultare:
Aldo di Ricaldone, Monferrato tra Po e Tanaro cap. X, p 484; Gribaudo Sedico
Mario Paluan, I tesori della valle di tufo, Sedico
Federico Cappello, Le grotte dei Saraceni, Associazione Amici della Natura di Casale e del Monferrato
Luigi Bavagnoli, Grotte dei Saraceni, L’ultimo mistero del Conte Mola, articolo del 28 dicembre 2011, Casale news, giornale on line.